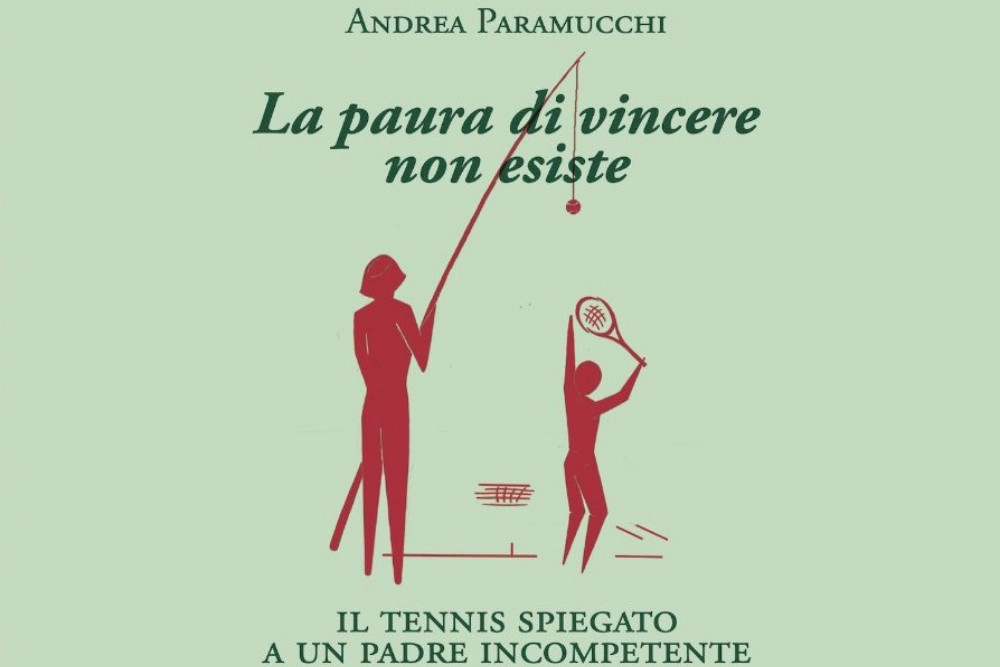Dietro quella pallina c’è un’anima. E per diventare un buon tennista non basta avere del talento e un fisico adeguato che lo supporti. È necessario qualcos’altro. Andrea Paramucchi, maestro romano di tennis di lungo corso, prova a dimostrarlo nel suo saggio, in un dialogo immaginario con un genitore. Il titolo è in qualche modo provocatorio: “La paura di vincere non esiste, il tennis spiegato a un padre incompetente” (Edizioni La parola, 20 euro, 224 pagine).
Vincenzo Santopadre, che ha guidato Matteo Berrettini sino alla finale di Wimbledon, scrive nella prefazione: “Andrea parla a tutti e di tutto: parla di tennis e di crescita personale, parla di tattica e di conoscenza di sé stessi. Non si tratta di istruzioni per la vittoria, ma di ricerca del proprio equilibrio e della consapevolezza di dove si è e dove si vuole arrivare. Un percorso di crescita che attraverso il tennis si estende in maniera naturale e logica alle tematiche essenziali della nostra vita”.
L’autore, prima di diventare maestro, fino a 21 anni ha svolto attività agonistica. E parte proprio dal suo fallimento come giocatore per analizzare stati d’animo e condizionamenti che impediscono un sano sviluppo del lavoro in campo e fuori. Il primo avversario da superare è la paura di vincere che, in realtà, è la paura di perdere quando si è a pochi passi dal traguardo. Vengono ricordati match epici come quelli tra Murray e Djokovic nella finale del Roland Garros del 2016 e tra Nadal e Djokovic nella finale del 2012 all’ustralian Open. Il dualismo vittoria e sconfitta riesce a provocare una tempesta di emozioni e chi è in grado di controllarla meglio, attraverso un percorso personale, supera la prova.

Traspare dalle pagine scritte, dove la principale preoccupazione è la ricerca di sé stessi, di quell’equilibrio che ti pone in condizione di colpire la palla in un modo piuttosto che in un altro. Gnothi seauton, conosci te stesso, scriveva Socrate e Paramucchi è un buon allievo, applicando la filosofia alla racchetta. La sua riflessione è senz’altro attuale in un tennis ora eccessivamente fisico. Ma l’intuizione che si apprezza di più è che sui campi prima viene il ragazzo, l’uomo, l’essere pensante e senziente, poi, eventualmente, il tennista. In questo, il tennis come metafora della vita può avere valore.
Si punta molto sulla mente e il cuore, sul percorso formativo di uno sport terribilmente individuale, in cui la solitudine della prova mette in discussione prima di tutto te stesso e poi l’avversario. Quante volte, ad esempio, abbiamo visto un Fognini o un Safin combattere prima di tutto con sé stesso, con i propri fantasmi e poi con l’avversario. Il talento sicuramente non basta. È necessario quell’equilibrio che ci si sforza di intravedere. E che, secondo l’autore, trascende, rendendo l’uomo fisico in metafisico.
Il tennis non è un fine, ma solo uno strumento. E la fiducia in sé stesso rappresenta la prima tappa da conquistare per arrivare al colpo giusto, quello che ti mette in armonia con gli altri. Si cita l’esempio di Jannik Sinner, che prima di raggiungere il tetto del mondo come numero 4 ha svolto con il suo team un gran lavoro sulla sua persona.
Ivan Ljubicic, numero 3 del ranking quando giocava e ultimo coach di Roger Federer, è pienamente d’accordo. Scrive nella postfazione: “Occorre allenare lo spirito, lavorare sull’anima, imparare a confrontarci con essa, riservando attenzione e tempo alla nostra dimensione spirituale”. Paramucchi azzarda: il tennis è lo sport dello spirito.
Antonio De Florio